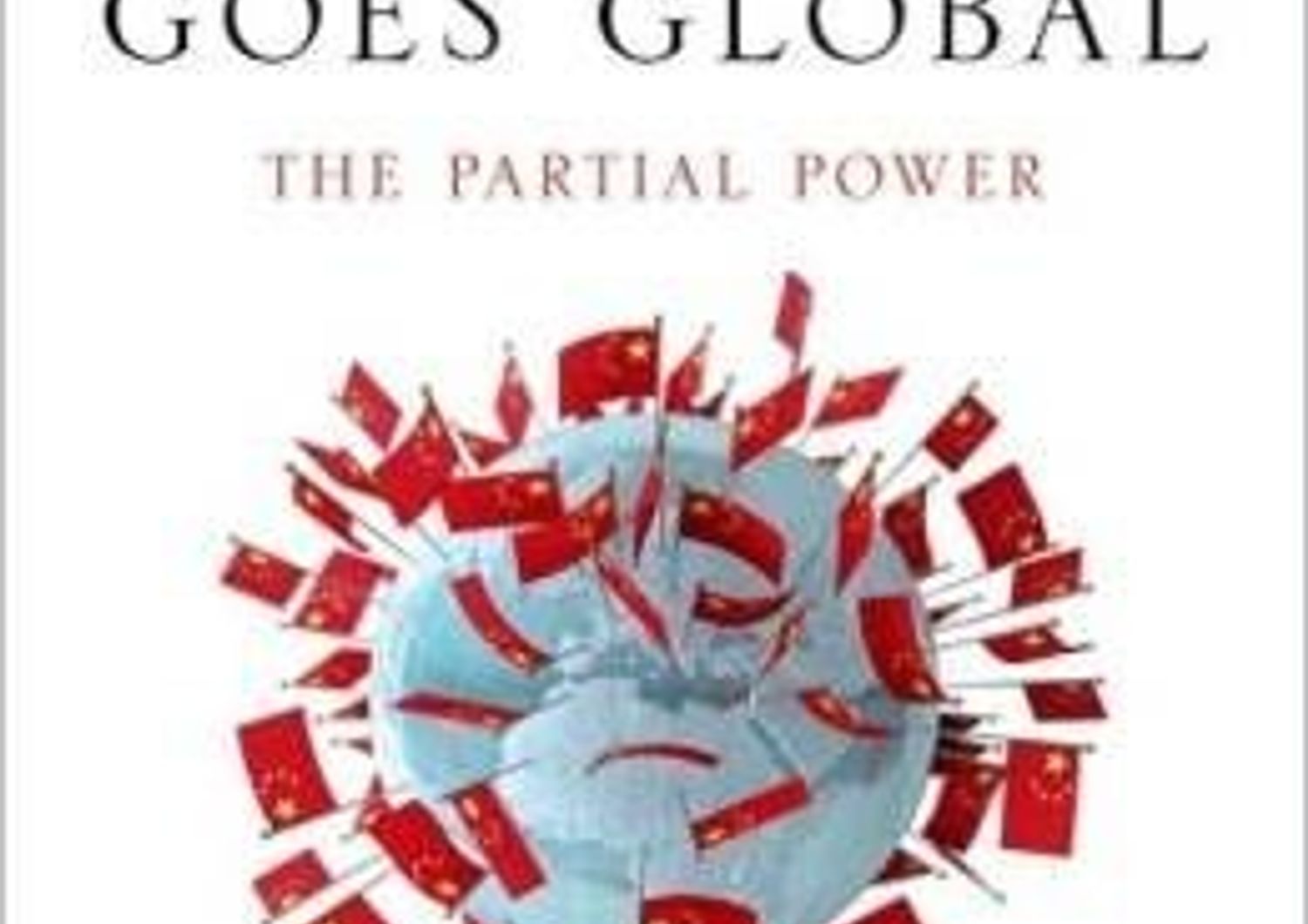di Davide Cucino*
Pechino, 24 apr. - Nella comune accezione, una nazione viene definita superpotenza grazie alla sua organizzazione politica e economica, e soprattutto alla credibilità e influenza che essa esercita nelle sue relazioni con il resto del mondo. Nella sua recente opera "China Goes Global. The Partial Power" (Oxford University Press), David Shambaugh si è dedicato all'analisi di quali enormi contraddizioni si siano originate nel corso di quest'ultimo trentennio con l'ascesa della Cina nello scacchiere internazionale. Ne scaturisce uno scenario in cui questo straordinario paese si trova a dover bilanciare la sua enorme propensione ad essere, insieme agli Stati Uniti, il maggiore attore globale. Una nazione assetata di materie prime e di prodotti alimentari, con il duplice obiettivo di soddisfare l'attuale fabbisogno interno e di mettersi al sicuro nel caso di una ipotetica emergenza futura. Sullo sfondo, la richiesta di assunzione di responsabilità nella governance globale che questo ingresso nello scenario internazionale comporta.
Ecco pertanto che il primo decennio del nuovo secolo è servito alla Cina da banco di prova. In primo luogo, in Asia, dove si è guadagnata un ruolo di leadership, senza tuttavia riuscire a impedire che molti paesi avvertissero con preoccupazione la spinta espansiva, soprattutto verso i mari orientali e del Sud-Est Pacifico. In secondo luogo, con una rinnovata diplomazia pubblica, anche se molto dimessa ogni qualvolta vi siano state da prendere decisioni difficili a livello internazionale adducendo la scusa della politica della "non interferenza".
Questa precarietà nell'esercizio di superpotenza è stata mitigata grazie alla crescita economica che, oltre a portare benefici al paese, ha anche - almeno per un certo periodo - entusiasmato le comunità d'affari di ampie aree del mondo, sia quelle in via di sviluppo (soprattutto l'Africa) che quelle già sviluppate. Infatti, l'economia di USA, Giappone e Europa hanno prima beneficiato degli investimenti in Cina - pur con grossi problemi di accesso al mercato soprattutto nei settori più strategici -, poi goduto di un forte incremento degli investimenti Cinesi negli anni più recenti.
L'opera di Shambaugh esplora con dovizia di esempi la catastrofica politica di promozione culturale Cinese; "disastrosa" a causa della convinzione da parte della leadership che il soft power "debba essere gestito, se non controllato dal governo". Un ulteriore capitolo è dedicato all'enorme sforzo di modernizzazione militare, promosso con la consapevolezza che "senza un esercito professionale" nessun paese possa veramente ritenersi una superpotenza, con un occhio agli "interessi centrali" territoriali e marittimi e un altro alla difesa per far fronte al contenimento americano in Asia degli ultimi anni.
Nelle sue conclusioni, Shambaugh propone una strada per trasformare il potere della Cina da precario a reale, proponendo un più spiccato coinvolgimento del paese, impegnandolo e integrandolo nel maggior numero di istituzioni e contesti in seno alla comunità internazionale. Ancora una volta emerge tuttavia l'insicurezza che da Pechino talvolta traspare, i suoi principi di politica estera antiquati e la scarsa propensione a intervenire durante le emergenze: la Cina, secondo lo studioso, ha bisogno di un "reset". Senza un sano confronto con il resto del mondo il pericolo nazionalista può essere sempre alle porte, con conseguenze disastrose per il mondo intero.
Davide Cucino, sinologo, è il presidente della Camera diCommercio Europea in Cina. Vive a Pechino da molti anni. Ha scritto"Tra poco la Cina" (Bollati Boringhieri). E' appassionato di libri.
© Riproduzione riservata