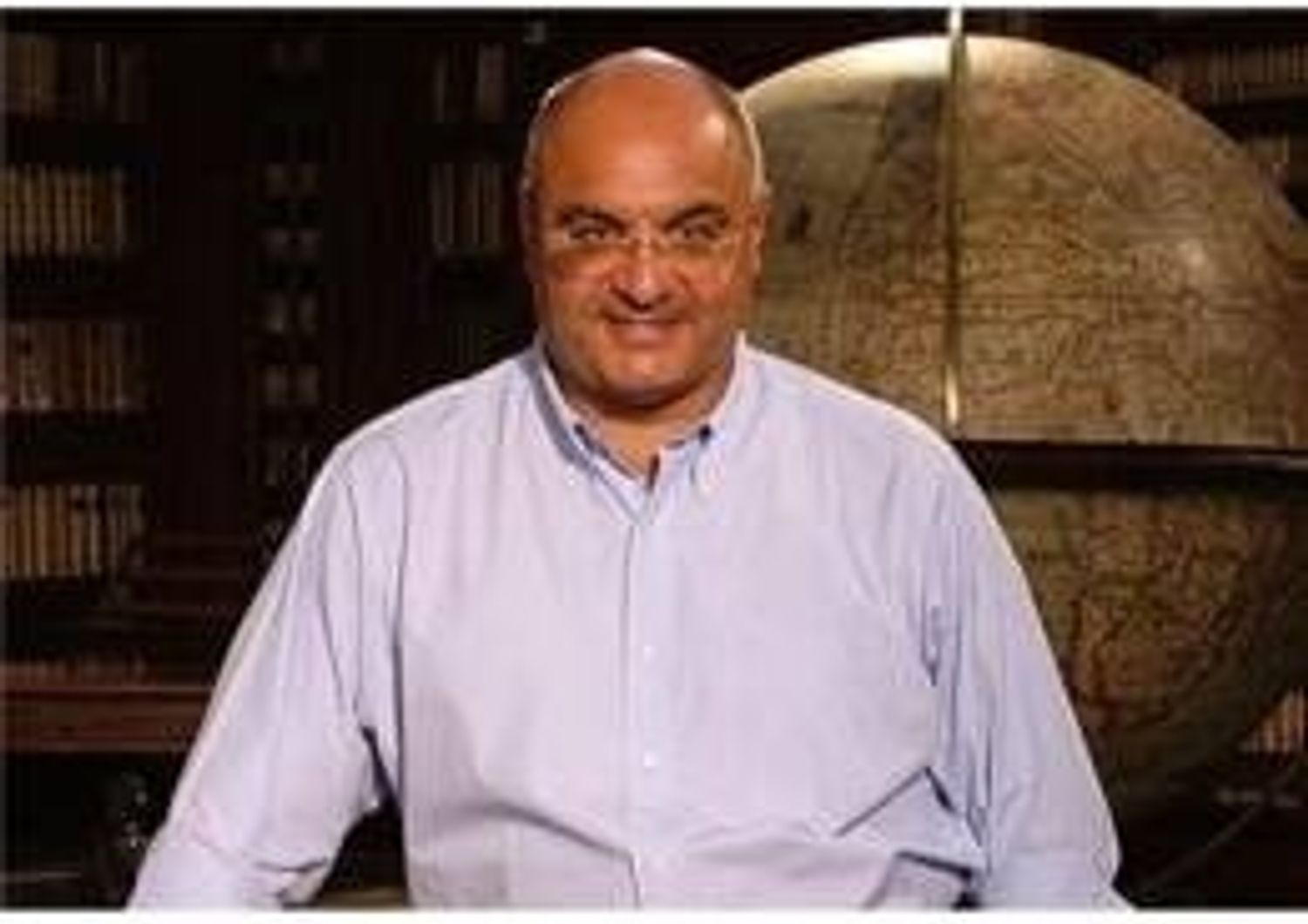Roma, 21 ott. - Corrado Ruggeri, giornalista, è responsabile della cronaca romana del Corriere della Sera, autore tra l'altro di "Farfalle sul Mekong", "Il Drago e la Farfalla". E' in libreria da maggio scorso il suo romanzo "Papà Mekong" (Infinito edizioni), con prefazione di Aldo Cazzullo, i cui diritti d'autore saranno parzialmente devoluti a Ecpat (End Children Prostitution in Asia Tourism).
Nei giorni scorsi il triangolo d'oro è tornato di nuovo sotto i riflettori. La Cina ha sospeso tutte le attività di navigazione sul tratto thailandese del fiume Mekong dopo l'assalto a due navi cinesi da parte di bande di narcotrafficanti. Questo fiume, che dalla sorgente del Tibet percorre l'Asia meridionale fino al Vietnam, è stato spesso teatro di conflitti, scontri e dissesti sociali, che fanno da sfondo ai suoi libri.
Il Mekong è una realtà complessa, bisogna risalire alla sua storia per capirlo. E' un fiume che nel corso dei secoli è servito po' a tutto, per far spostare persone da una terra all'altra, ma anche per traffici illeciti. Ricordiamo che nasce in Tibet e scorre fino al Vietnam, attraversando Myanmar, Thailandia, Laos e Cambogia, Paesi che sono stati teatro di enormi dissesti politici, e che è stato utilizzato anche per trasporti di contrabbando di stupefacenti, gioielli, armi. E', insomma, un fiume controverso. Nel corso della storia lo hanno chiamato "il fiume della memoria del diavolo", oppure "il sangue che scorre nelle nostre vene", appellativi che rappresentano un attaccamento forte ma ambivalente nei suoi confronti. Poi è diventato il fiume della guerra, un fiume rosso sangue su cui scorrevano le atrocità del conflitto in Vietnam, con tutte le loro implicazioni politiche ed emotive.
La situazione è resa più complicate dal quadro attuale. Può spiegarlo?
Ad oggi la situazione generale è quella di paesi in via di sviluppo che tentano di risollevarsi, ma che si muovono a velocità molto diverse fra loro. La Thailandia è sicuramente la realtà più sviluppata. E' un Paese avanzato che ha un industria produttiva e che sta progredendo, anche attraverso la valorizzazione del turismo, pur essendo ancora afflitta dalle piaghe sociali della prostituzione, del turismo sessuale e della povertà nelle zone più remote. La Cambogia vive ancora oggi una realtà difficile, anche se si sta tentando di risollevarla. Ci sono state molte iniziative per rivitalizzare la capitale Phnom Penh, che sta lentamente riconquistando una certa gradevolezza estetica, ma i problemi sociali che la affliggono ne ostacolano i progressi. Anche il Vietnam continua sulla sua via di sviluppo, in cui il delta del Mekong ricopre un ruolo fondamentale per l'economia, per le coltivazioni di riso e per l'accesso al Mar Cinese Meridionale.
Quali sono le ripercussioni di questi dissesti sul tessuto sociale, e come vanno a interferire sullo status quo?
Bisogna ricordare che in questi luoghi la gente è sempre vissuta nella "scomodità" quotidiana e sociale, spesso a vedere queste realtà la nostra è una reazione di sorpresa, quasi di sgomento, ma si tratta semplicemente di stili di vita differenti. C'è chi mangia cani e topolini di campagna arrostiti, chi vive sulle barche, chi ancora segue ritualità antiche e non ha idea di cosa sia un condizionatore d'aria. In questo contesto, il crescente contatto con l'Occidente e le immagini della società moderna e globalizzata cambiano le carte in tavola, creano squilibri e tensioni all'interno della società, ma anche germogli di cambiamento. Ed è anche legittimo che la vita migliori per tutti. Le tensioni derivano dal passaggio da un mondo di tipo rurale a uno di "aspirazione capitalistica", che esalta la ricerca del denaro. Un fenomeno sociale recente in Cambogia è la vendita delle terre dei contadini a società internazionali. Il contadino venditore gioisce della fortuna accumulata con l'affare ma, dopo qualche tempo, resta inevitabilmente senza nulla, in uno sviluppo mal indirizzato, deludente e poco produttivo.
Traffico di droga e turismo sessuale hanno prodotto "assuefazione"?
Anche in questo caso c'è da considerare che la droga e la coltivazione dell'oppio fanno parte di queste culture, come per certi aspetti è l'alcol nella nostra. Diventa crimine internazionale nel momento in cui assume grandi proporzioni, come ad esempio nel caso del grande trafficante Khun Sa, che nel 1996 aveva creato un impero nel traffico di droga, con un suo esercito di coltivatori di oppio, e operava su scala internazionale. Un astuto criminale che alla fine la passò liscia trattando una specie di salvacondotto col governo birmano. In casi del genere è chiaro che bisogna distinguere tra perpetuare la propria cultura e fare i criminali internazionali.
Come si comporta la comunità internazionale?
Non c'è mediazione, nel momento in cui il fenomeno diventa criminale bisogna attaccarlo frontalmente. A questo scopo è stato concepito un programma dalle Nazioni Unite per sostituire le coltivazioni di oppio con quelle di altri prodotti agricoli, che giovano comunque al profitto dei contadini. E' proprio questo il punto: non importa che sia oppio, granturco o riso, basta che garantisca la possibilità di sopravvivere. Dall'implementazione di questo programma di sviluppo, la produzione di oppio nel triangolo d'oro è molto diminuita, si è spostata in altre zone dell'Asia centrale, come ad esempio l'Afghanistan. Ma è chiaro che ci sono ancora zone in cui sussiste il problema, altrimenti non si verificherebbero questi incidenti oggi. La prostituzione è invece legata a una mentalità in cui il sesso è ancora associato a tradizioni spesso brutali. C'è un forte squilibrio tra uomo e donna, per cui quest'ultima è spesso vittima di maltrattamenti, e vengono ancora osservate credenze che garantiscono forza e longevità agli uomini che hanno rapporto con le vergini. O ancora, esistono famiglie che non riescono a mantenere i propri figli e preferiscono saperli nei bordelli piuttosto che vederli soffrire la fame, fenomeno alimentato dalla piaga internazionale della prostituzione minorile. Fortunatamente l'operato di molte Onlus sta migliorando la situazione, ma c'è ancora molta strada da fare.
Sul versante politico assisteremo a delle aperture democratiche?
E' un viaggio lungo. E ci sono molte realtà diverse: il Vietnam ha un suo percorso avviato che procede su una propria via di sviluppo che combina socialismo ed economia di mercato, la Cambogia ha fatto del trasformismo politico la sua caratteristica, il leader attuale Hun Sen, è stato il numero due di Pol Pot che poi passò dalla parte dei vietnamiti, per diventare in ultimo filooccidentale. Un personaggio "all'italiana", se vogliamo…
Il Myanmar, pur mostrando timidi segnali di apertura, resta una nazione chiusa, di cui non si sa nulla. La Thailandia è un Paese che ha un'economia che tiene e che va avanti, tra le innumerevoli contraddizioni che la contraddistinguono. Se parliamo di strategia a lungo termine, prima o poi dovranno aprirsi alla democrazia, o per lo meno ad uno stato di diritto più affermato. Si tratta, però, di un percorso molto lungo.
L'attacco alle due navi cinesi sul Mekong ha portato la Thailandia ad accusare il Myanmar di non arginare il traffico di droga. Cosa è accaduto?
E' difficile sapere la verità in queste situazioni. E va ammesso che noi occidentali tendiamo a giudicare attraverso preconcetti. E' chiaro che tra Myanmar e Thailandia istintivamente è difficile credere al Myanmar. Si pensa che le cose siano andate come le espone la Thailandia, ma le dinamiche sono talmente complesse che bisognerebbe analizzarle in una prospettiva più ampia.
di Annunziata Rispoli
ARTICOLI CORRELATI
12 morti in Thailandia, triangolo d'oro nei riflettori
© Riproduzione riservata