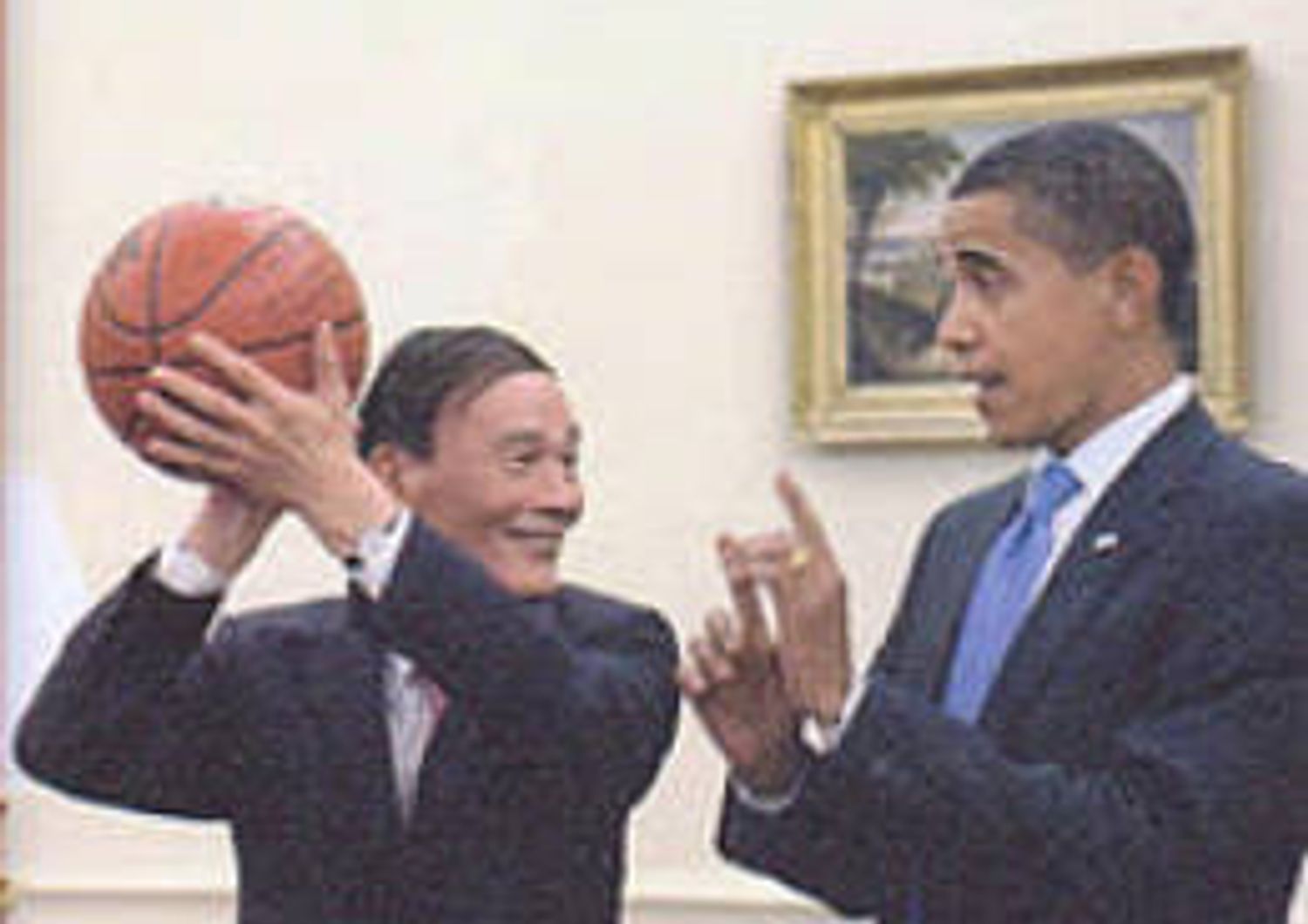Roma, 07 nov. - Come schegge di shrapnel, i brevi paragrafi nei quali brilla a centinaia di colpi l'ultimo libro di Geminello Alvi ("Il capitalismo - verso l'ideale cinese", Marsilio ed. 335 p., 21 euro) investono chi legge con molteplicità di spunti e di richiami. Tesi e antitesi che sembrerebbero provocatorie se sin dal tono stesso dell'esposizione non se ne librasse una ancorché complessa assertività. Ecco dunque il capitalismo occidentale che spedito s'approssima, preda della sua stessa febbre, verso i modelli omologanti standardizzati dai cinesi. Alvi ritrova una chiaroveggente enunciazione di John Stuart Mill dall''On Liberty' - "dimenticato a memoria" nei libri di sociologia - per istigare il dubbio "se non sia questa fase del capitalismo a omologarci all'isterica piattezza cinese".
Non è però soltanto questo: ci sono numeri e analisi aggiornati fino agli accadimenti d'oggi di cui l'autore si serve per disvelare il "camuffamento d'Oriente", cui ricorre il dispotismo di Pechino (e Wittfogel, da Alvi, è naturalmente citato) assumendo anche le maschere delle corporations e delle banche occidentali per espandere e disporre del proprio potere. Spietato, Alvi sostiene: "I cinesi hanno il capitalismo, ma non il capitale, sono cioè posseduti dall'invidia di massa che fa loro reclamare nelle città il superfluo, e però non hanno l'io, la libera esistenza". Non suo, si puntualizza, è il copyright della teoria, ma del filosofo gesuita Teilhard de Chardin, il quale proponeva in una lettera del 1927 l'ipotesi dei cinesi quali "primitivi arrestati, degli 'infantili' la cui stoffa antropologica sarebbe inferiore alla nostra". Delirio di paleontologo, se assunto alla lettera. Eppure lo scienziato francese parve (e pare) realistico allorché aggiungeva che tra gli Han "tutto ciò che tende a elevarsi viene immediatamente riportato a zero. Tutto ciò che vive a lungo in mezzo a loro è psicologicamente sminuito, snervato".
Se non fosse altrettanto spietato con l'emisfero occidentale, imperdonabile risulterebbe tuttavia il libro di Alvi. Ma l'autore si rivela, fortuna del recensore, non meno severo verso il capitalismo americano e nei confronti di un'Europa declinante - o declinata - in cui si gioca la tragica "commedia dell'euro" amministrata da Francia e Germania. Chi ricorda di avere registrato Alvi, già diversi anni orsono, sulle stesse posizioni dovrà riconoscergli perlomeno coerenza e un'aliquota di quella certa preveggenza che tanto gli fa amare Mill.
Quando cita l'assioma: "Gli stessi principi, una stessa moneta con parità diverse, le stesse leggi", Alvi non riferisce una frase di Barroso né di Van Rompuy. E' bensì Napoleone. E perciò, ne conclude che "non il liberismo, ma un errore atavico, quindi, ha covato l'euro".
Quel che muove in verità l'economista è l'impulso éliotiano di puntellare le rovine sulla terra desolata del capitalismo attuale, che tradisce il capitale, appiattisce le individualità e restringe l'io. Che produce stati alterati di coscienza catturando nel ragno del web, che si riproduce nell'invidia collettiva motrice di bisogni fittizi e consumi compulsivi. Non ci sono solo il geniale ma "svenevole" Keynes, o Greenspan, "scriteriato pianificatore in stile sovietico della stampa di denaro statale". C'è pure il vocabolario esagitato di 'Vanity Fair', c'è il patetico Pip dickensiano con le relative "great expectations" ingenue e luciferine a far da cemento al costrutto di Alvi. Che ha forse non a caso, in questa ultima prova, addensato e contratto il passo della prosa, ne ha dismesso le trascorse riuscite tentazioni di eleganza per accentuare i tentativi della suggestione. E così difatti - forse solo così - dal pericardio, può essere assorbito un libro ove si smontano con raziocinio i criteri statistici fondanti le notizie economiche, primo fra tutti il Pil, ordigno artificioso e recente che pure è per convenzione e convinzione diffusa misura di tutte le cose, Graal degli uffici studi, di ragionieri dello stato e ministri molto pensosi. Graal parimenti giornalistico e profano assai, che custodisce "la noia ossessa di un'umanità in monomania economica". ("Il Pil e il Pnl - desacralizza Alvi - sono strumento statistico di omologazione di quanto non è prodotto per il mercato, come i costi dello stato o dell'istruzione o della sanità, ma viene finto tale. E' il riflesso mentale quotidiano e indotto che fa considerare normale che prima funzione dello stato o della cultura sia produrre valore").
C'è tuttavia - e non per mero dovere d'ufficio - una 'pars construens' che suggella il libro e lo distingue da un testo di seppure interessante invettiva intellettuale. Meno numeroso per pagine, ma più essenziale, è l'appello di Alvi per una economia "omerica", quella della minore crescita e della più giusta distribuzione. L'appello a un ritorno al logos inteso letteralmente come "parola detta", "non sintetizzata elettronicamente, senza gli stati alterati di tv e di internet o l'uso dei microfoni, l'espressione devota: il free speech che ora abbisogna".
E' un ordine economico meno fondato sugli Stati e più orientato alle istituzioni tradizionali, dalla famiglia alle comunità intermedie, che riconosca l'atto epico del "dono" come "solidarietà cosciente e premeditata", prevalente sulla burocrazia pubblica. E' la rivolta (o meglio la revulsione) dell'io contro l'omologazione che perverte ogni forma.
Se non fosse economista ma poeta, Alvi avrebbe dipanato la sua tesi in versi simili a quelli di un altro steineriano (ché è questa dottrina senza dubbio intrinseca al libro né l'autore lo cela). Stiamo rammemorando Arturo Onofri, il quale titolò "Vincere il Drago!" una certa sua raccolta: "E' carità di noi, esseri ignari,/vivere in terra offrendo agli alti cieli/le lacrime e i sudori necessari;/ma onnipotenza d'uomo, nella vita,/è fede che a noi - spiriti - si sveli/in ogni affanno una virtù scolpita". Ad altro Drago, più che alla Cina fisica, riportano alla fine questi versi di Onofri, quelle righe di Alvi.
di Francesco Palmieri
© Riproduzione riservata