Antonio Montucci e l'avventura del dizionario cinese


Il bel libro di Donatella Cherubini, Una famiglia tra Siena e l’Europa. I Montucci 1762-1877 (Milano, Franco Angeli, 2017), dedica molto spazio a un famoso membro di quella famiglia, Antonio Montucci (1767-1829), che scoprì e coltivò il cinese senza essere mai andato in Cina, com’era il caso di molti letterati del tempo interessati all’Oriente che mai visitavano. Montucci può essere annoverato un serio pioniere europeo di studi cinesi. L’autrice lo affronta più da umanista che da “sinologo” nella sua complessa e travagliata figura di intellettuale vissuto entro e fuori del mondo “senese” del Sette-Ottocento nei suoi contatti e rapporti nelle varie capitali europee con personalità di spicco (uno Vittorio Alfieri tra Siena e Londra).
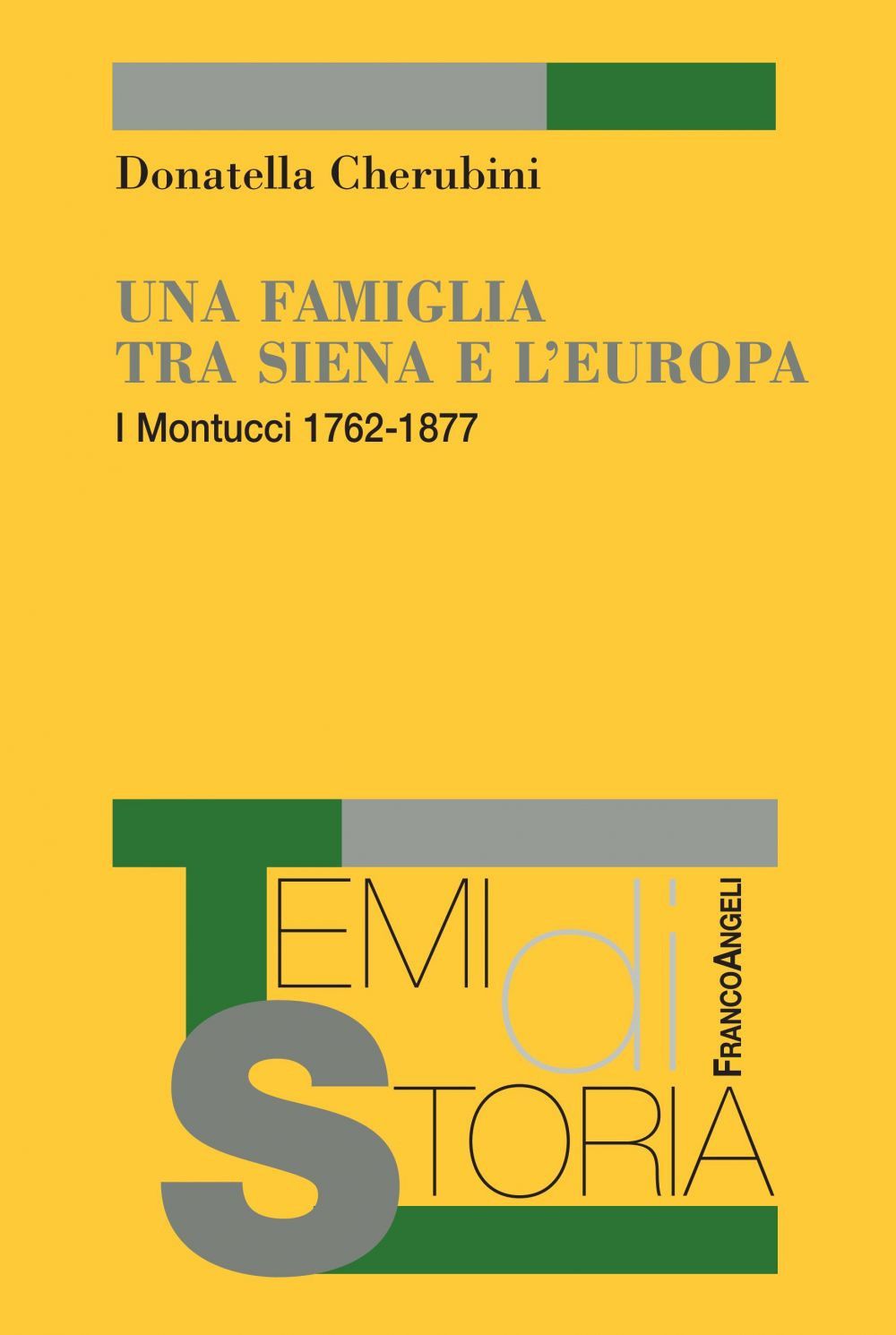
Laureatosi nella città natale in utroque iure nel 1785, Montucci, ben versato nell’inglese, era nello stesso anno nominato professore di questa lingua nel collegio Tolomei della città. Lasciata Siena per Firenze, si costruiva molte aderenze presso la locale comunità anglosassone e aveva l’occasione di raggiungere Londra come “precettore di lingua toscana”, con lui che si presentava “Professore di Scienze e Belle Lettere”; dal 1791 Montucci iniziava una frenetica attività editoriale di opere proprie e altrui per lo più attinenti all’insegnamento linguistico-letterario. “In parallelo”, ricorda l’Autrice, “le avrebbe affiancate con altri generi di pubblicazioni, specialmente sulla lingua cinese”, e in francese, tedesco e latino manifestando almeno dal 1804 “l’indomita aspirazione ad affermarsi come linguista di dimensione europea, da oltre un decennio sempre più interessato al cinese”. Oltre un decennio prima Londra era stata in fermento per i preparativi dell’ambasceria di Lord Macartney in Cina, e lo stesso Montucci vi si era coinvolto avvicinando due allievi cinesi del Collegio sinico di Napoli che erano stati presi al seguito dell’ambasceria.
Tra le edizioni de “L’Orientale” di Napoli erano pubblicati negli anni scorsi due saggi di Michele Fatica che incrociavano questo esordio di Montucci aspirante sinologo. Il primo era “Il contributo degli alunni del Collegio dei Cinesi di Napoli alla conoscenza della lingua sinica in Europa” e il secondo “Gli alunni del Collegium Sinicum di Napoli, la missione Macartney presso l’imperatore Qianglong e la richiesta di libertà di culto per i cristiani cinesi (1792-1793)”, quest’ultimo incluso nel secondo volume degli Studi in onore di Lionello Lanciotti (1996).
Aggiungeva dunque Fatica che Montucci, già in qualità di Segretario di Sir Horace Mann a Firenze (che ne scopriva l’attitudine per le lingue), era mandato a Londra presso il negozio di Josiah Wedgwood che commerciava in ceramiche di una propria manifattura. Interessato a conoscere i metodi cinesi di fabbricazione della porcellana, Wedgwood trovava in Montucci la persona disposta a cercargli i testi cinesi in materia e soprattutto decisa a intraprendere anche lo studio del cinese, partendo dalla famosa Grammatica di Étienne Fourmont e dal Museum Sinicum di Gottlieb Siegfried Bayer. Ma il vero colpo di fortuna di Montucci era l’incontro che aveva nel 1792 coi due sacerdoti del Collegio dei Cinesi che erano stati condotti a Londra da Sir George Leonard Stauton in soprannumero agli interpreti scelti per la missione a Pechino, e durante il protratto soggiorno londinese i due si prestavano a perfezionare Montucci nelle sue conoscenze di cinese scritto e parlato non mancando di lasciargli dei testi in lingua e un dizionario cinese.
Fin qui Fatica. Attrezzatosi dunque come sinologo, Montucci maturava la decisione di compilare e stampare un primo dizionario sulla scorta di un altro in sue mani, che era forse quello secentesco cinese-latino di Basilio Brollo da Gemona una cui copia manoscritta aveva avuto occasione di acquistare a Londra. Cominciava a dotarsi anche dei necessari caratteri per la stampa.
Montucci era però all’oscuro dei precedenti, numerosi e vani tentativi che aveva avuto la stampa del dizionario di Brollo e di quanto si veniva ancora facendo in quei giorni per pubblicarlo. Scrive l’autrice: “Un passaggio nevralgico [per Montucci] fu segnato tra il 1800 e il 1801, quando l’orientalista italiano Giuseppe Hager si dichiarò in procinto di pubblicare un dizionario cinese […] e lo fece da Londra […]. Montucci ne fu assai contrariato, reagì immediatamente e a sua volta pubblicò un proprio progetto per la medesima impresa, criticando duramente Hager. Assieme all’autorevole e competente berlinese Julius Heinrich von Klaproth dette vita a una serrata controversia […]. E nelle lettere private definiva l’avversario un impostore…”.
Giuseppe Hager (1757-1819) non era un impostore. Era un po’come Montucci un improvvisato cultore di studi cinesi dopo essersi fatto a Palermo un nome come arabista e fama di esimio orientalista. Giovanissimo aveva frequentato a Vienna l’Akademie der orientalischen Sprachen, dove aveva forse studiato lingua araba. Quindi addottoratosi in teologia all’Università di Pavia nel 1783, aveva preso i voti di minorita francescano da cui aveva receduto all’imposto scioglimento governativo dell’ordine nel 1786, tornando alla vita laica. Il successivo trasferimento a Roma lo portava a Propaganda Fide ove forse cominciava allora ad avvicinarsi allo studio del cinese. Passato a Londra, nel 1800 lanciava la proposta di stamparvi su sottoscrizione un dizionario e l’anno dopo pubblicava sempre a Londra An Explanation of the elementary Characters of the Chinese (che avrebbe avuto una ristampa a Menston addirittura nel 1972), un saggio che gli rinnovava il credito e la fama che gli avevano già assicurato le prime pubblicazioni di studi arabistici apparse in Sicilia.
Tardandosi in Inghilterra la raccolta dei fondi necessari alla stampa, Hager accettava nel 1802 una chiamata dalla Francia che gli proponeva la pubblicazione del dizionario in francese, ma durante il soggiorno parigino che pure gli fruttava alcune pubblicazioni sinologiche, si alienava molti appoggi, mentre subiva la campagna denigratoria di Montucci e Klaproth e infine la revoca dell’incarico da parte del governo francese. Pertanto nel 1806 Hager rientrava in Italia deluso e amareggiato, mentre Montucci, visto vano sperare anche lui nell’affidamento da parte della Francia, si trasferiva lo stesso anno a Berlino per realizzare l’impresa con Federico Guglielmo III di Prussia.
Lo scoppio delle guerre napoleoniche rendeva pure lì vano il progetto, mentre esso era ripreso in Francia dove il riferimento tornava a ricadere sul vecchio dizionario di Brollo che era stato nel secolo precedente già almeno in parte predisposto per i caratteri di stampa da Matteo Ripa, fondatore del Collegio dei Cinesi di Napoli, su incarico di Propaganda Fide a Roma. In Francia aveva intanto avuto una prima stampa parziale a cura del cinese Arcadio Huang (m. 1716) e di Fourmont (m. 1745) su commissione diretta di Luigi XIV. Nel 1802 i caratteri in piombo per la stampa erano stati portati presso le Imprimeries Impériales di Parigi, e Napoleone ne caldeggiava l’ulteriore utilizzazione. Napoleone intendeva fare della Francia un grande centro di studi cinesi e, avendo messo gli occhi sul Collegio dei Cinesi di Napoli , si proponeva di trasferirlo a Parigi valutandolo uno strumento politico importante per la penetrazione francese in Asia. Leggiamo in Gennaro Nardi, Cinesi a Napoli. Un uomo e un’opera (Napoli, Edizioni Deoniane-PIME, 1976): “Affidò a un alunno del collegio l’incarico di compilare un dizionario latino-cinese. Il lavoro restò incompleto per la morte dell’alunno, ma fu mandato lo stesso in Francia; nulla poi si seppe di esso”.
Il decreto governativo francese del 22 ottobre 1808 designava affidatario del dizionario Chretien Luis Joseph de Guignes (1759-1845), già console di Francia a Canton, figlio del “sinologo” Joseph de Guignes (1721-1800). De Guignes figlio dava quindi alle stampe a proprio nome il Dictionaire chinois-français-latin, dopo essersi per lo più limitato ad aggiungere i corrispondenti francesi ai lemmi cinesi e latini del dizionario di Brollo; Abel-Rèmusat e Klaproth, ne denunciavano la frode.
Donatella Cherubini scrive: “Antonio Montucci non desisteva nell’impresa del dizionario, ma ancora una volta fu preceduto: un nuovo attacco polemico lo mosse contro il pastore e missionario inglese Robert Morrison, il primo che riuscì a pubblicare un dizionario cinese autentico grazie al sostegno della East India Company. Diviso in diversi tomi, il dizionario di Morrison fu stampato a Macao in Cina, facendo però figurare anche Londra, fra il 1815 e il 1823”.
A quel punto non rimaneva a Montucci che rassegnarsi al fallimento: cedeva in vendita nel 1824 a Propaganda Fide sia i propri libri e sia l’attrezzatura tipografica che tanto gli era costata in fatica e denaro per finire col rientrare in Italia e ritirarsi definitivamente nella Siena nativa, dove morendo lasciava la moglie e il figlio Caterino Enrico, nato a Berlino nel 1808.
Giovani Vacca (1872-1953) scriveva in Un secolo di progresso scientifico Italiano 1839-1939, oggi in rete, che Montucci “vendeva la sua biblioteca di libri cinesi e la sua ricca collezione di caratteri cinesi intagliati in legno al Papa Leone XII. Questi caratteri, molto eleganti, opera di valenti incisori cinesi, si conservano nella Tipografia di Propaganda Fide, nella città del Vaticano”. Non ci è noto come Montucci ne fosse entrato in possesso e dove e da chi fossero stati intagliati.